|
|
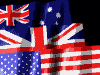 |
|
 
|
| |
 |
| |
|
Come prima cosa bisogna affermare che ciò che
possiamo dire dell'animale è sulla base di ciò che lui stesso ci comunica coi
suoi gesti, i suoi versi, i suoi comportamenti. Non bisogna pensare che
l'animale abbia cose maggiori da comunicarci e che non possa farlo perché
impedito da carenza di mezzi di comunicazione, anche se così fosse, ma così non
è, saremmo in
grado di comprendere la sua comunicazione come siamo capaci di imparare una
lingua diversa o comunicare attraverso gesti con un muto. Questa considerazione è di immediata evidenza per chiunque.
Quello che ci comunica l'animale è tutto quello
che ha da comunicare. E' sulla base di questa sua comunicazione che noi
rileviamo la distinzione ontologica tra noi e l'animale.
L'animale può essere addestrato, può in ambito di
addomesticamento acquistare tratti cospicui di relazionalità con l'uomo, ma
sempre l'animale comunicherà la sua sostanziale differenza.
L'animale può affezionarsi all'uomo,
sono notissimi casi di cani che si sono lanciati contro un avversario per
difendere il padrone, oppure di cani che si sono messi ad abbaiare per
richiamare l'attenzione sulla presenza di un pericolo. Noto il cane Argo di
Ulisse, che riconosce il padrone dopo tanto tempo. Ancor più noto è quanto dice
il Vangelo circa le pecore che riconoscono la voce del pastore, che le chiama
una per una, mentre non seguono la voce di un estraneo (Gv 10,1-8).
La Bibbia, senza paura di essere smentita, dice
che Adamo riconobbe immediatamente come sua compagna la donna, Eva,
distinguendola immediatamente da tutti gli animali. Adamo vide in lei la sua
stessa natura razionale, oltre che la sua relazione corporea.
Quando noi descriviamo i caratteri della conoscenza
degli animali percorriamo di necessità la strada dell'analogia con quanto
sperimentiamo in noi in comportamenti simili. Facciamo dunque solo
un'interpretazione. Era questo che esprimeva Hegel quando diceva: “man
weis nie diesen Bestien steckt” (non si sa mai cosa c'è in queste bestie)
(Cit. Vanni Rovighi: “Elementi di filosofia”, ed. La Scuola, Brescia
1963, Vol III, pag. 107).
È un errore ideologico quello di
pensare che l'animale ha coscienza di sé come noi, e usare quindi il
termine autocoscienza. La nostra coscienza di sé è infatti
radicalmente diversa da quella dell'animale, essendo quella di un animale
razionale, cioè che ha un'anima razionale, spirituale. La nostra coscienza di sé
è autocoscienza.
Un termine
come autocoscienza, coniato per esprimere noi, non può essere usato
per altri che per noi. Allora quale termine utilizzare per esprimere che
l'animale percepisce se stesso? Al solito bisogna rispondere in modo che non risulti
confusione con la realtà uomo. Ecco, se io tocco la zampa di un gatto tocco il
gatto, infatti tutto il gatto reagisce. Dunque, l'animale è un'unità e sente non
solo sulla zampa quando lo tocco, ma sente anche che interpello tutta la sua
unità, perché proprio è un'unità; non è un automa meccanico, una pura somma di
meccanismi, ma un essere vivente che possiede una percezione istintiva di se
stesso, diversa dalla percezione che l'uomo ha di sé, tanto diversa che l'uomo non può vivere l'esperienza percettiva di un animale, ma solo averne un’analogia. Questa percezione che l'animale ha di sé, con quale termine si può esprimere senza fare confusione con la nostra
coscienza di sé, evento intellettivo/corporeo immediato, che esprimiamo, appunto, col termine
autocoscienza?
Il filosofo Sofia Vanni Rovighi, (“Elementi di
filosofia”, Vol III, pag. 107) usa il termine cosciente per la vita
sensitiva, intendendolo però come conoscenza in senso generalissimo, nel senso
generalissimo di awareness. Così vien detto che l'animale è un
essere cosciente, mentre l'uomo è un essere autocosciente, cioè ha
la coscienza di sé.
Tutto ciò è molto giusto e ben calibrato,
tuttavia per non far confusione con la coscienza, propria dell'attività morale
dell'uomo, e per marcare decisamente la differenza tra il percepire la propria
unità dell'animale e il percepire proprio dell'uomo si possono coniare altri
termini. Ad esempio, dell'animale si può dire che è sensiente, nel senso
che la conoscenza (cum-scientia: conoscenza) che l'animale ha della sua unità, non dell'io, avviene solo mediante la percezione dei sensi.
L'esperienza
dello specchio condotta su animali non svela niente di nuovo che l'animale abbia
da comunicarci. Trovarsi di fronte ad uno specchio d'acqua, è un'esperienza
comune agli animali, e non fa loro problemi. Un'antilope che va a bere in una
pozza d'acqua limpida, o in un laghetto, o in un'ansa pacifica di un fiume
limpido vede la sua immagine; la vede fin dai primi giorni della sua vita e
quell'immagine le diventa familiare; la vede come altra cosa da sé,
come figura nell'acqua, ma pur la riconosce procedente da sé perché
corrisponde ai suoi movimenti.
Comunque, c'è
chi ha creduto di carpire qualcosa di nuovo osservando il comportamento di
animali davanti ad uno specchio, o meglio dentro il quadro intellettuale
dello sperimentatore, ma gli animali hanno continuato a dire che sono animali.
Così Gordon G. Gallup (“Chimpanzees: self-recognizion”
(auto-riconoscimento), Science 1970, 167, pp. 86-87).
Gordon G. Gallup, che lavorava alla
State University of New York ad Albany, prese alcuni scimpanzé e li pose davanti ad uno
specchio a tutta altezza e ve li lasciò per dieci giorni. Gli scimpanzé,
che evidentemente non avevano mai fatto l'esperienza di bere in una limpida
pozza d'acqua, cominciarono ad agitarsi come se si trovassero di fronte ad altri
scimpanzé. Pian piano (esaminiamo un singolo scimpanzé) lo scimpanzé cominciò a
relazionarsi con quell'immagine che non costituiva nessuna reale relazione
combattiva o affettiva e non emanava nessun odore, nessun verso, solo seguiva i
suoi movimenti. L'animale giunse ad assuefarsi a questa esperienza nuova:
nessuna minaccia, nessun odore, nessun verso, dunque una realtà in sola relazione con l'unità di sé, percepita in quanto
sensiente.
Lo sperimentatore, poi, prese gli scimpanzé e li
anestetizzò e in tale stato pose loro una macchia sul volto in alto in modo che
non la potessero vedere. La macchia era di sostanza inodore e quindi
non poteva attrarre per questa via l'animale. Gli animali usciti dallo stato di
sonno vennero posti subito a contatto tra di loro e videro la macchia gli uni
gli altri e questo creò uno stato psicologico che richiedeva che la novità
macchia fosse percepita anche su di sé, e in effetti gli animali toccarono alcune
volte quella macchia che vedevano negli altri, ma non su se stessi.
Poi gli animali vennero posti di nuovo davanti
allo specchio L'immagine alla quale ogni animale si era assuefatto era diversa,
comprendendo, appunto, una macchia. Senso di smarrimento. La nuova immagine
urtava con la precedente. L'animale che si era già rapportato con la sua
immagine a partire dai movimenti che faceva, doveva ristabilirne il rapporto. Non
potendola vedere direttamente con l'occhio, usava l'odorato mettendo, molto più
di prima, le dita sulla macchia vista nello specchio, e poi fiutandole per
conoscerne l'odore. Via, questa, impercorribile poiché la macchia era inodore.
L'animale poneva anche spesso le dita sulla macchia senza poi annusarle.
Conclusione dello sperimentatore? L'animale si
auto-riconosceva (self-recognizion). La parola
auto-riconosceva è un'espressione posta per confondere, perché l'animale
semplicemente si riconosceva nello specchio: un conto è riconoscersi
in un uno specchio, un conto è auto riconoscersi in uno specchio, che implica l’autocoscienza di sé. L'animale rimane sempre un essere
senziente.
Moltissimi hanno visto in casa loro come si
comporta un cane davanti a uno specchio. Nei primi momenti l'animale crede di trovarsi di
fronte ad un antagonista o ad un partner, come accade nell'esperimento di
Gordon, ma poi pian piano giunge l'assuefazione vedendo che l'immagine non lo
impegna in una relazione con qualche altro cane, e con l'esperienza del fenomeno-specchio, giunge
a riconoscersi. Un animale non si pone davanti ad uno
specchio per specchiarsi.
Riguardo all'acquisizione del significato di
parole o di segni, l'animale vi giunge sempre per associazione: segno-oggetto, e
ciò avviene per ottenere il premio del cibo dallo sperimentatore. Cioè impara ad associare una parola
udita con ciò che designa e si rivolge all'oggetto designato, non per via della
comprensione della parola, ma per la modulazione della parola alla quale
l'addestratore ha fatto corrispondere una cosa verso cui dirigersi, per poi dare
del cibo. Ciò che viene chiamato in gioco è sempre l'istinto che è alla base
della vita sensitiva dell'animale.
Sono stati addestrati scimpanzé anche per mezzo
del linguaggio gestuale dei muti, in tal modo essi imparano molte parole e fanno le
azioni corrispondenti a quelle parole ripetutamente eseguite con il premio
del cibo. Le sequenze di gesti fatti dall'animale addestrato sono risultate
all'esame dei filmati gesti confusi per compiacere l'addestratore in vista del
premio e non una attività ordinata di comunicazione. Il modo di procedere
dell'animale è quello dell'associazione sotto la guida dell'istinto. Evidentemente, per quanto addestrato, lo scimpanzé non può agire oltre le sue
capacità: non si potrà mettere a fare il muratore con tanto di filo a piombo,
ecc.
Si sono cercati sempre mezzi più sofisticati per gli esperimenti, come computer appositamente costruiti con tasti sui quali vengono tracciate immagini, colori, ma l'animale continua ad agire sempre nel quadro rigoroso dell'istinto e dell'associazione delle immagini, che riceve dal senso senza alcuna possibilità astrattiva. Quello che si è notato è che hanno una forte memoria visiva, ed è con questo supporto, che opera l’associazione connessa all’istinto.
Ma ecco l'animale addestrato dallo sperimentatore in maniera spinta, per carpirne i segreti, o troppo spesso per vedere verificate le proprie ideologie di evoluzionismo dall'animale all'uomo, non è altro che un animale piegato nelle sue possibilità nella direzione voluta dall'addestratore e di conseguenza l'animale smarrisce altre possibilità che aveva naturalmente, come saper accudire i propri cuccioli, e quindi alla fin fine viene compromessa la perfezione che aveva.
Uno scimpanzé in stato di libertà può utilizzare
una bacchetta dopo averla liberata dai rami laterali per infilarla in un
termitaio e così prendere le formiche per mangiarle. Ma non può assolutamente
con uno strumento costruire un altro strumento più perfezionato, il che vuol
dire che può lanciare una pietra, ma poi non può usare la pietra per scheggiarne
un'altra ricavandone un rasoio o una punta acuminata.
È stato visto un gorilla allo stato libero che
si appoggiava ad un bastone mentre traversava un corso d'acqua, ma ciò non gli
dà la possibilità di elaborare uno strumento usandone un altro. Ricordo che le
scimmie non sanno nuotare e che il loro procedere eretto è quanto mai precario,
nessuna meraviglia se quel gorilla trovando un bastone e trovandosi di fronte ad
un corso d'acqua da attraversare abbia elaborato sulla scorta dell'istinto e
dell'esperienza quel procedere eretto, per non affogare, sostenendo la sua
posizione eretta con un bastone.
Chi non conosce
gli animali finisce per dire sciocchezze.
Il 17
giugno 2011,
durante il tg1 delle
ore 20, è stata
data la notizia che in uno zoo inglese, un orango del Borneo di 16 anni
di nome Jorong, aveva salvato un "cucciolo" di gallinella d'acqua
dall'annegamento usando come strumento di salvataggio una foglia. Non risultando
questo efficace, prese il "cucciolo" nella mano e lo pose in salvo a terra.
Esaminando il video su You Tube le cose stanno altrimenti. L'orango prima ha
visto l'uccellino, che non stava affatto annegando, anzi il video dimostra che
sapeva ben nuotare, quindi ha preso una foglia e gliel'ha posta ripetutamente
sul becco. Successivamente, ha preso in pugno l'uccellino e l'ha posto a terra e
ha cominciato, stando accovacciato, ad esaminarlo da vicinissimo. Per due volte
l'ha sollevato all'altezza della bocca e sembrava che dovesse mangiarselo. In
seguito, l'ha posto a terra e se ne è disinteressato. Quello che appare con
chiarezza è che l'orango ha solo studiato la nocività o meno dell'uccellino.
Prima è attratto da un essere che nuota (scimpanzè, gorilla, orango non hanno
propensione per il nuoto), poi
saggia il becco della gallinella d'acqua con una foglia, questo più volte per
vederne la combattività. Non più pauroso la prende in pugno e la pone a terra.
Quindi ancora la esamina da vicino. Due volte se la porta alla bocca in un esame
finale, che ai presenti è parso un moto per mangiarsela, e vede che non è né
utile né nociva e se ne disinteressa. Precisamente, l'utile e il nocivo è ciò
che ha mosso l'orango, recluso dentro lo zoo accanto ad uno specchio d'acqua.
Non credo che ci sia qualcuno che non abbia visto come una cane domestico fiuta
un nuovo arrivato, amico del suo padrone; gli gira attorno fiutandolo (non
bisogna irrigidirsi perché ciò viene interpretato come un atto di combattimento)
e poi, rassicurato anche dalla presenza del suo padrone,
l'animale rimane tranquillo.
L’animale utilizza quello che trova rispondente al suo utile, così, ad esempio, l’uccello fa il suo nido con rametti e fango, ma non elabora un modo più sviluppato di fare il suo nido; un’industria dell’abitazione. Alla ricerca di cibo non diventa agricoltore o allevatore con tanto di recinto, ma prende quello che trova in base alla sua natura di erbivoro o carnivoro o onnivoro. L’animale non elabora una conoscenza della realtà per poterla sfruttare, scheggiando pietre per avere utensili o cercando nelle rocce minerali per fonderli e avere oggetti più idonei e versatili, in una tensione di sviluppo tecnologico.
L’uomo non coglie soltanto il fenomeno, ma vuole sapere come avviene quel fenomeno, quali sono le cause di
quel fenomeno; e così sviluppa il suo pensiero scientifico che lo porta a grandi altezze, pur cosciente dei suoi limiti di fronte alla potenza del creato. L’uomo
fa le cose, le plasma, ma si domanda pure quale sia l’Artefice primo e supremo di tutte le cose. Per questo possiede, per la sua natura razionale datagli da un’anima spirituale, un
istinto razionale (non istinto animale) che lo sospinge a concepire l’esistenza di un Creatore di tutte le cose.
L’uomo sente il bisogno di rapportarsi con il Creatore avvertendo la sua assistenza. Infatti Dio non solo esiste, ma anche esiste come amore per l’uomo. Da qui il pensiero religioso, del tutto proprio dell’uomo.
Quello che non potrà mai essere soppresso, è che c'è un salto ontologico tra l'uomo e l'animale.
Le cose sono chiare. Il somaro raglierà fino alla fine del mondo, il bue muggirà fino alla fine del mondo, il leone farà lo stesso; il serpente sibilerà sino alla fine del mondo, la Jena ululerà sino alla fine del mondo, e così via.
L’uomo ha la parola, espressione vocale del pensiero. Così ha potuto formare una varietà innumerabile di linguaggi, e ancora conia parole, espressioni, per nuove situazioni e cose. Il canarino farà il suo canto, di poche note, fino alla fine del mondo. L’uomo ha dato vita alla musica con ricchezza di strumenti sviluppati nel tempo; ha dato vita a diversi generi musicali: danza sacra, sinfonia, opera, colonna sonora di film, musica lirica, musica leggera, e il suo talento musicale non si esaurisce.
Ma anche riguardo alle possibilità del corpo l’uomo è sorprendente. Può arrampicarsi con l’agilità di una scimmia, può nuotare come un pesce, può strisciare a terra come un serpente, può volare con salti e dare spettacolo acrobatico con i trapezi e con l’atletica artistica. Corre veloce e incede eretto con un passo da sovrano su tutto.
L’animale ha una facoltà psichica radicalmente inerente
solo alla
percezione sensibile. La si chiama intelligenza pratica-istintiva (facoltà aestimativa presso i filosofi scolastici) o
intelligenza appercitiva, perché essenzialmente legata alla percezione sensibile, e differisce sostanzialmente dall'intelligenza astrattiva o intellettiva, che è propria dell'uomo.
Ha sentimenti l’animale? Qua bisogna intendere, infatti la parola sentimento nasce dall’osservazione dell’uomo su di sé e ha una valenza che include la ragione, la quale motiva, approfondisce, il nascere di una simpatia che diventa poi un sentimento per qualcuno, e ciò sulla base delle qualità di una persona, non solo fisiche, che sarebbe poco, ma spirituali. Per questo la parola
sentimento va lasciata all’uomo mentre per l’animale dobbiamo per correttezza usare una parola di minore portata quale è
affezione. Certo l’animale si affeziona, ricorda con affezione il padrone, il branco. Ha fedeltà al padrone (cane addomesticato) difendendolo, riconoscendolo. Se prendiamo altro animale come un leone, vediamo che si può addomesticare. Un domatore di leoni prende il cucciolo fin dai primi suoi giorni, gli dà da magiare, e pian piano lo addestra dandogli ad esercizio eseguito del cibo. L’animale, infatti, si muove nell’ambito
dell’utile e del nocivo e se il "domatore" gli è utile per il cibo si lega pian piano a lui. L’animale ha una sua vita di relazione con
l'addestratore. Comunque, sappiamo che nei circhi a volte ci sono sorprese di leoni che aggrediscono l’addestratore, così come avviene per le orche, e qui pare proprio che non sia corretto piegare l’istinto di un animale con modi anche crudeli (vedi le orche) per farne uno spettacolo sensazionale.
Possiamo dire che l’animale ha emozioni (paura, dolore, aggressività, contentezza), ma nel suo ambito di istinto. Anche l’uomo ha emozioni, ma sono sempre proprie di un soggetto razionale, che può dominare la paura anche provandola, che può sostenere il dolore pur provandone repulsione, che sa dominare la rabbia pur sentendola affiorare, che è contento per motivi alti, ad esempio, mangiare il pane frutto del suo lavoro.
|
| |
 |
| |
|
Solo l'uomo ha l'anima razionale, spirituale. L'animale non la possiede
assolutamente, e non siamo noi a dirlo, ma sono gli animali stessi che lo
affermano con i loro comportamenti. Il mondo vuole negare l'anima all'uomo
riducendolo ad animale, ma ciò non è. La filosofia ben vede la differenza tra
l'uomo, animale razionale in quanto ha l'anima, e l'animale. La Bibbia poi
presenta con chiarezza inequivocabile come l'animale non abbia l'anima.
All'animale non fu dato un soffio di vita direttamente da Dio (Gn 2,7).
L'animale viene tutto dalla terra (Gn 2,19). Gli animali Dio li dà come cibo
all'uomo, per essi non c'è l'obbligo di non ucciderli (Gn 9,3). Il salmo
(48/49,13.21) dice: "Ma nella prosperità l'uomo non dura: è simile alle
bestie che muoiono (...). Nella prosperità l'uomo non comprende, è simile alle
bestie che muoiono". il salmo (73/74,22) dice: "Io ero insensato e non
capivo, stavo davanti a te come una bestia". Gli animali vennero usati per i
sacrifici (Gn 4,4; 8,20; 22,13; Es 12,21; Lv 1,2s; Nm 15,3). Nei giorni
prescritti il tempio sembrava un ammazzatoio e il sangue scorreva a torrenti (Cf.
1Re 8,63). A Pietro comparve dal cielo una grande tovaglia con dentro animali di
ogni sorta, mondi e immondi secondo le prescrizioni giudaiche, e una voce gli
disse di uccidere e mangiare per invitarlo a non pensare di essere contaminato
dai cibi che si ritenevano immondi (At 10,13): "Coraggio, Pietro, uccidi e
mangia!". Il sangue dei sacrifici degli animali non ha valore salvifico (Eb
10,4-7): "E' impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i
peccati. per questo, entrando nel mondo. Cristo dice: Tu non hai voluto né
sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: <Ecco io vengo - poiché
di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà>".

Sofia Vanni Rovighi (1908 - 1990), docente di
filosofia teoretica, morale, e storia della filosofia presso l'Università
Cattolica “Sacro cuore” di Milano; autrice di notevoli pubblicazioni, nel
1980 ricevette il premio “Antonio Feltrinelli” per le scienze filosofiche
dall'Accademia Nazionale dei Lincei. Dal Volume III di “Elementi di Filosofia”,
ed. La Scuola, Brescia 1963, pag 171s. Riporto questi passi per la sua esemplare
chiarezza.
(pag. 171-177):
“E ragioneremo così: se c'è nell'uomo un'attività
indipendente dal corpo; se c'è un'attività umana che non può procedere dal
corpo, che non può avere il corpo come soggetto, c'è nell'uomo una realtà, un
ente, indipendente dal corpo. Se c'è nell'uomo un'attività che, pur essendo
dell'uomo (e quindi procedendo dalla sua forma sostanziale), non può procedere
da un soggetto corporeo, dovremo dire che l'anima, la forma sostanziale
dell'uomo, sussiste per sé, poiché l'attività non è altro che una manifestazione
dell'essere. La nostra ricerca si orienta quindi verso una qualche attività
umana che trascenda il corpo, che non possa procedere dal corpo.
S. Tommaso ce ne indica tre: la conoscenza
dell'universale, la riflessione o autocoscienza, la capacità dell'intelletto di
conoscere tutti i corpi.
Conoscenza dell'universale e
contemplazione
Cominciamo dalla prima. L'universale è ciò che
prescinde dal qui e dall'ora: è, diremmo, un aspetto svincolato
dalle condizioni che legano l'essere dell'oggetto alle condizioni della
corporeità, spazio e tempo; il conoscere per universali indica quindi nel
soggetto conoscente una superiorità rispetto a tali condizioni, una certa
indifferenza dominatrice rispetto ad esse.
Facciamo ora qualche considerazione
sull'argomento esposto. La conoscenza dell'universale risponde alla ricerca
dell'essenza, del che cosa è una cosa, prescindendo dal suo esserci per
me, dall'interesse vitale che essa può avere per me hic et nunc; è
insomma l'atteggiamento contemplativo. E contemplazione vuol dire in certo senso
distacco dagli interessi vitali, animali. Quando questi prevalgono, e sono
impellenti, non c'è contemplazione primum vivere, deinde philosophari. E
non pensiamo soltanto alle più alte attività contemplative, pensiamo anche a
quelle della nostra vita quotidiana, che hanno bisogno di otium, di libertà, di
liberazione, vorrei dire, dai bisogni più urgenti della vita animale. Se sono
per la strada, e vedo o sento un veicolo che sta per venirmi addosso, mi
affretto a scansarmi, a salire sul marciapiede, ad attraversare: reagisco
vitalmente, pressappoco come reagirebbe un puro animale, perché la necessità di
salvare la mia vita animale prende il sopravvento. Ebbene, se ora rifletto e mi
domando: che cosa ho conosciuto quando mi sono scansato? Mi accorgerò che ho
conosciuto quel veicolo solo come una cosa per me illic et tunc
minacciosa. Non mi sono domandato che cosa era: se non un camion, un
furgoncino, un'automobile. Queste cose me le domanderò dopo; quando sarò sul
marciapiede e avrò l'otium di contemplare, quando non sarò più assorbito
dall'esigenza di salvare la mia vita animale.
In quanto contemplatore l'uomo si dimostra, dice
M. Scheler, come l'asceta della vita: ora per superare in qualche modo le
esigenze della vita animale bisogna essere più che animale.
E abbiamo detto che questa capacità contemplativa
dell'uomo si manifesta anche nella conoscenza più banale: nella conoscenza della
vita quotidiana, in quella nella quale definiamo questo come un carro e
quest'altro come un automobile. La nostra spiritualità, infatti, non è un
vestito della festa che si manifesti solo nelle grandi occasioni, ma è il
carattere della nostra natura, che si deve poter scorgere in tutto ciò che è
umano.
Contemplazione e tecnica
Se pensiamo un momento alla tecnica, vedremo
comparire anche lì qualche cosa che trascende la pura vita animale. Se c'è una
attitudine diretta proprio al bene dell'uomo in quanto animale, all'utile,
questa è la tecnica: quando pensiamo al tecnico, o meglio all'uomo in quanto
tecnico, all'homo faber, lo pensiamo più vicino al castoro che non a un
Angelo. Eppure anche nella tecnica si manifesta la spiritualità dell'uomo. Non
sembra infatti che la tecnica dei castori progredisca (ndr. I castori hanno
due sistemi per fare le dighe, a seconda della situazione: uno è quella di
infiggere rami sul fondo del corso d'acqua per ancorare la struttura, se il
fondo si presta, e poi addossandovi rami e anche tronchi; l'altro è quello di
usare sassi, fango e rami e tronchi, formando pian piano una barriera al corso
d'acqua. Il castoro è un continuo taglialegna per rendere sicure le sue dighe,
che permettono di avere un accesso sott'acqua e quindi protetto per difendersi
dagli animali predatori. La tana è poi aerata con un foro in alto)., mentre
progredisce quella dell'uomo. Si dirà: sono i bisogni che fanno progredire.
Tutt'altro: è la tecnica che fa sentire nuovi bisogni. I bisogni animali
dell'uomo sono infatti fondamentalmente sempre gli stessi: mangiare, bere,
dormire, ripararsi dalle intemperie, ecc. Noi sentiamo oggi il bisogno di una
cucina a gas o di un frigorifero elettrico non perché si siano destate nuove
esigenze animali, ma perché sappiamo che ci sono cucine a gas e frigoriferi
elettrici coi quali si fa più presto e si impiega meno fatica a far da mangiare
e si conservano meglio i cibi.
Se ora ci domandiamo quale molla, soprattutto, fa
progredire la tecnica, dobbiamo rispondere che è l'interesse teoretico,
l'interesse speculativo, l'interesse per il problema in sé. Questa affermazione
farà forse ridere gli uomini d'affari - e farà ridere anche coloro che leggono
gli elogi della tecnica solo sui libri; ma chi ha avuto la ventura di stare
vicino ad un tecnico appassionato (e quale mai tecnico non appassionato può far
progredire la tecnica?) sa che la molla del suo lavoro è l'interesse teoretico.
Dietro il tecnico, a stimolarlo, a dargli i mezzi, ci sarà un imprenditore che
mira al profitto o uno stato totalitario che mira alla potenza, ma gli uomini
d'affari non riuscirebbero a far quattrini, e i politici avidi di potenza non
avrebbero strumenti a loro disposizione se non adoperassero i risultati ottenuti
da ricercatori appassionati, che sono spesso uomini candidi, più affini ai poeti
e agli scienziati puri che ai loro finanziatori, e spesso, come attesta la
storia contemporanea, sono angosciati al pensiero dell'uso che può essere fatto
delle loro scoperte.
Ho preso l'esempio della tecnica proprio perché
essa è l'attività umana più orientata ai bisogni della vita animale: ma cosa
dobbiamo dire dell'arte, della filosofia, della religione? Di queste attività
umane nelle quali si manifesta la passione dell'uomo per “l'inutile”,
l'interesse per ciò che non serve ai bisogni animali?
Libertà e spiritualità
Pensiamo agli atteggiamenti pratici che seguono
la conoscenza intellettiva.
Pensiamo specialmente ai casi in cui l'uomo, con
la sua libertà, si manifesta indifferente anche alla sua vita animale, alla sua
conservazione. E' possibile che un ente distrugga la sua natura? E allora, se
l'uomo accetta volontariamente la morte, vuol dire che è qualcosa di più di ciò
che con la morte si distrugge. Non paragoniamo, per carità, la morte liberamente
accettata dall'uomo col suicidio del cane che si lascia morir di fame sulla
tomba del suo padrone. A questo sarà paragonabile il suicidio della fanciulla
che ha perduto l'amato bene o, in genere, dell'uomo che ha perduto una persona
cara: suicidio dovuto a una carenza vitale, a incapacità di reagire, di
ristabilire il proprio equilibrio dopo una scossa. Ma ben altro è l'accettazione
volontaria della morte per un ideale morale, ossia non perché si è incapaci di
vivere, ma per affermare in modo più alto e più forte il proprio essere. E,
infatti, anche le teorie materialistiche, quando chiedono all'uomo il sacrificio
della propria vita, debbono cercare un surrogato di spiritualità e di
immortalità, debbono parlare della gloria, o del bene del popolo ipostatizzando
questo popolo fino a farne la sostanza spirituale dell'umanità. Se infatti
l'umanità fosse un gregge di animali bruti si potrebbe sì capire che il padrone
del gregge ne sacrificasse uno o dieci, per salvarsi il resto, ma non si
potrebbe capire perché uno del gregge dovesse sacrificarsi volontariamente per
gli altri: uno varrebbe l'altro.
Riflessione e spiritualità
Se il principio intellettivo fosse corporeo,
dovremmo dire o che esso è un corpo per conto suo, accanto al corpo animato di
vita sensitiva, oppure che è lo stesso corpo animato. La prima ipotesi è
scartata, poiché il principio intellettivo (ndr.
L'anima razionale) è la forma
sostanziale del corpo. Resterebbe dunque la seconda, che è quella storicamente
propugnata dalle filosofie materialistiche. Secondo questa ipotesi la conoscenza
intellettiva si svolgerebbe mediante un organo corporeo, il cervello. Ora, ci si
domanda, in tal caso sarebbe possibile l'autocoscienza? Il soggetto avrebbe
bisogno di un organo corporeo per conoscere: quindi dovrebbe averne bisogno
anche per conoscere il suo conoscere; ma se l'organo è già impegnato nella
conoscenza diretta, come potrebbe essere disponibile per la conoscenza riflessa?
Ci vorrebbe un secondo organo per la riflessione (ndr. Non si dica che ci può
essere una zona del cervello che agisce come un organo [autocoscienza]
sull'organo cervello nel quale si trova, poiché questo è contrario alle
esperienze che mostrano che sì vi sono aree con attività selettive, ma le aree
non sono affatto dei compartimenti autosufficienti. Il cervello, infatti, non è
un insieme di sistemi indipendenti, ma è l'unione di componenti
interdipendenti). E allora non avrei più coscienza di conoscere la mia
conoscenza; il primo atto conoscitivo non sarebbe autocosciente. L'occhio non
vede se stesso mentre vede: può vedersi solo allo specchio, e nello specchio si
vede come altro, come vedrebbe qualsiasi altro oggetto.
Nella Summa Contra Gentiles, S. Tommaso
applica questo argomento in senso più ampio ed osserva che la riflessione indica
una presenza a sé che non è compatibile con l'estensione, la quale
disperderebbe, per dir così, il soggetto in una molteplicità di parte e
impedirebbe che ci fosse un sé in senso proprio, cioè come un soggetto che si
possiede in qualche modo nella riflessione. Riflettere, infatti, essere
autocoscienti, vuol dire in certo modo possedersi, coincidere con sé, non essere
dispersi.
Si pensi poi che la riflessione è la radice della
possibilità di dominarsi. Riflettere su un nostro sentimento, atteggiamento, è
il primo passo per poterlo dominare: finché ci siamo immersi, finché lo viviamo
soltanto, non ne siamo padroni; solo quando lo oggettiviamo possiamo dominarlo.
Ma, si dirà, qualche volta con la riflessione noi
ci accorgiamo proprio di essere in certo senso dominati dalla nostra vita
animale. Si dice: se io non avessi avuto fame o non fossi stato stanco in quel
momento non avrei risposto così male, non avrei reagito così vivamente. Ma
questo prender coscienza della nostra dipendenza dal corpo non è già una prova
che siamo più di quello che si è lasciato dominare? Questo aver coscienza di
essersi lasciati dominare non è una prova che emergiamo per una parte di noi
dall'animalità? Se fossi tutto dominato, non mi accorgerei di essere dominato.
Non si ha coscienza di essere chiusi in una stanza se non si ha una idea di ciò
che è fuori della stanza stessa, e, vorrei dire, se non si è vissuti un po'
fuori della stanza.
Il terzo argomento tomistico, quello che si fonda
sulla nostra capacità di conoscere tutti i corpi, mi sembra vada ricondotto a
quello della conoscenza dell'universale. (Summa theol., q. 75, aa. 2).
Conclusione
Queste considerazioni ci portano a concludere che
ci sono in noi attività indipendenti dal corpo, e perciò che il soggetto di tali
attività è indipendente dal corpo.
Si noti, innanzitutto, per non trovare
contraddizioni con quel che si è detto prima, che non abbiamo cercato prove
della nostra spiritualità in pretese intuizioni dello spirituale, ma nel modo
in cui conosciamo gli stessi corpi.
Anche la conoscenza intellettiva, dunque, dipende
in certo modo dal corpo, come è attestato dal fatto che quando il cervello
subisce certe lesioni, l'uomo è impedito anche nella conoscenza intellettiva. Ma
questo si può spiegare senza negare la spiritualità dell'anima, se si ammette
che, mentre per la conoscenza sensitiva il corpo è consoggetto di
attività (ossia chi opera, chi sente, è il corpo animato, non l'anima
sola), per la conoscenza intellettiva invece il corpo fornisce l'oggetto
(l'immagine) dal quale con l'intelletto astraiamo la specie intellegibile e
formiamo il concetto”.
|
| |
 |
| |
Il rapporto dell'uomo con gli animali deve essere
rispettoso della loro natura non violentarla, per cercare di conoscere chissà
che cosa. San Francesco ha voluto bene agli animali e gli animali hanno
avvertito col loro istinto che egli era buono.
Aggiornato all'11 febbraio
2025 |
|